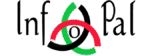Gaza – Presstv. Nessuna guerra nella storia moderna ha causato così tanti morti nella stampa, né la Seconda Guerra Mondiale, né il Vietnam, né l’Iraq o l’Afghanistan. Gaza è diventata il luogo più letale al mondo per praticare il giornalismo.
A Gaza oggi, dire la verità può costare la vita.
Quasi 300 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi dall’inizio della campagna genocida israeliana a Gaza, iniziata due anni fa.
Secondo l’osservatorio “Shireen Abu Akleh”, la stragrande maggioranza erano palestinesi.
La Federazione Internazionale dei Giornalisti conferma che almeno 246 giornalisti sono morti in tutta la regione, 223 dei quali nella sola Gaza.
Non si tratta di morti accidentali o sfortunate coincidenze. Sono il risultato, affermano molti osservatori dei diritti umani, di una campagna deliberata per mettere a tacere i testimoni.

La Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla Libertà di Espressione, Irene Khan, l’ha definito “un tentativo di uccidere la storia. Israele prima delegittima i giornalisti, etichettandoli come simpatizzanti del terrorismo, e poi li elimina. Non si tratta solo di uccidere i giornalisti; si tratta di uccidere la verità”.
Il 10 agosto 2025, un attacco aereo israeliano ha colpito una tenda che ospitava i giornalisti fuori dall’ospedale al-Shifa della città di Gaza. Cinque dipendenti di Al Jazeera sono stati uccisi. Tra loro, il noto corrispondente dell’emittente, Anas Al Sharif.
Solo poche settimane prima, un portavoce dell’esercito israeliano aveva accusato Al Sharif di essere un membro dell’ala militare di Hamas. La sua morte, come tante altre, rientra in uno schema ormai familiare: un’accusa pubblica seguita da un attacco.

Israele nega di aver preso deliberatamente di mira i giornalisti, ma gruppi per i diritti umani, le Nazioni Unite e le organizzazioni per la libertà di stampa hanno raccolto prove che suggeriscono il contrario.
Reporter Senza Frontiere ha presentato cinque denunce separate alla Corte Penale Internazionale, accusando di crimini di guerra e attacchi deliberati ai danni di giornalisti a Gaza.
La loro denuncia più recente, risalente all’agosto 2025, documenta i casi di 30 giornalisti attaccati dalle forze israeliane, 25 dei quali uccisi.
Ai giornalisti stranieri è stato impedito l’ingresso a Gaza per gran parte della guerra. Le uniche eccezioni sono un piccolo numero a cui è stato permesso di accompagnare le truppe israeliane sotto una rigida censura militare.

Ciò significa che la comprensione mondiale di questo conflitto, le immagini, i resoconti dei testimoni oculari, la documentazione della distruzione, dipendono quasi interamente dai giornalisti palestinesi che lavorano all’interno dell’enclave.
Si tratta di giornalisti che hanno sopportato sfollamenti, fame, sfinimento e paura costante, eppure continuano a documentare la devastazione. Con la corrispondenza internazionale tenuta fuori, sono diventati gli ultimi testimoni rimasti al mondo.
Per Israele, questo controllo della narrazione non è casuale. I critici affermano che la campagna del regime per gestire ciò che il mondo vede è strategica quanto le sue operazioni militari; il controllo delle informazioni, sostengono, fa parte del controllo del territorio.
Dall’ottobre 2023, Israele ha bloccato l’accesso ai media stranieri, censurato la copertura mediatica nazionale e messo al bando le testate giornalistiche ritenute ostili ai suoi obiettivi di guerra.

L’entità delle perdite tra i giornalisti è sconcertante. Secondo il Costs of War Project della Brown University, a Gaza sono morti più giornalisti che in tutte le principali guerre americane che hanno coinvolto giornalisti, dalla Guerra Civile Americana al conflitto in Afghanistan dopo l’11 settembre.
La Federazione Internazionale dei Giornalisti, che l’anno prossimo festeggerà il suo centenario, afferma di non aver mai registrato un simile massacro tra le sue fila.
Gaza, avvertono, è diventata il cimitero del giornalismo.

Ma dietro ogni statistica c’è un essere umano, un giovane operatore che corre verso il fumo invece che allontanarsene, un corrispondente radiofonico che compila un ultimo reportage prima che salti la corrente, una madre che manda un messaggio ai figli prima di uscire a filmare un altro bombardamento.
Le famiglie aspettano invano il ritorno dei propri cari dal campo. Spesso ciò che torna indietro è una borsa fotografica o un gilet da stampa coperto di polvere o sangue. Per molti, la sopravvivenza è diventata secondaria rispetto alla testimonianza.
La guerra ha anche messo in luce le faglie degli stessi media occidentali: anche se i giornalisti palestinesi rischiano tutto per documentare le atrocità, il loro lavoro spesso fatica a penetrare i filtri dell’informazione globale.
In molti media mainstream, la copertura mediatica si è basata pesantemente sulle dichiarazioni ufficiali e sulle inquadrature israeliane.
Il linguaggio stesso è diventato un campo di battaglia.

Nonostante una Commissione delle Nazioni Unite abbia stabilito che le azioni di Israele equivalgono a genocidio, la maggior parte dei principali media occidentali si è rifiutata di usare il termine. Le parole vengono addolcite, le atrocità edulcorate e, nel frattempo, la verità che i giornalisti palestinesi muoiono per rivelare viene spesso diluita fino a renderla irriconoscibile.
Come ha osservato uno studioso dei media, quando le immagini raggiungono le redazioni occidentali, vengono filtrate dalla necessità di apparire equilibrate, e questo equilibrio spesso va a discapito dell’accuratezza.
Ciò che rende Gaza così devastante per il giornalismo non è solo il numero di vite perse, ma il significato di queste morti.
Quando i governi apprendono che uccidere i giornalisti non ha conseguenze reali, creano un precedente. Dicono al mondo che mettere a tacere la stampa può essere un legittimo strumento di guerra, e il mondo finora lo ha permesso.
Né le Nazioni Unite né le grandi potenze sono intervenute per proteggere i giornalisti sul campo.

Gli Stati Uniti, il principale sostenitore militare di Israele, continuano a fornire armi, nonostante le prove di attacchi sistematici continuino a crescere; il silenzio è assordante.
La massima insegnata in ogni scuola di giornalismo, “nessuna storia vale una vita umana”, era intesa come regola di sicurezza, non come una resa. A Gaza, questo principio è stato messo a dura prova. I giornalisti rimasti conoscono i rischi.
Filmano dai tetti, sapendo che i droni israeliani riconoscono i gilet della stampa; montano i servizi con la luce delle torce, sapendo che un attacco potrebbe porre fine alle loro vite in qualsiasi momento, eppure persistono, perché fermarsi significherebbe silenzio e il silenzio significherebbe cancellazione.
Anas Al-Sharif, il corrispondente di Al Jazeera ucciso nell’agosto del 2025, una volta disse in un’intervista: “Non vogliamo essere eroi, vogliamo solo essere ascoltati”.

Le sue parole ora risuonano come un epitaffio collettivo per i 223 giornalisti palestinesi morti dall’inizio della guerra. La loro morte non è solo una tragedia per le loro famiglie o la loro professione; è una tragedia per la verità stessa.
Se il giornalismo è la prima bozza della storia, allora la storia viene scritta a Gaza, nel sangue e nella polvere. Ogni giornalista caduto è una pagina strappata da quella storia.
La domanda per il mondo è se permetteremo che quelle pagine scompaiano o se finalmente affronteremo cosa significa vivere in un’epoca in cui uccidere i giornalisti è diventata routine, perché quando i testimoni se ne vanno, le bugie rimangono, e senza testimoni non c’è storia, solo propaganda.

Traduzione per InfoPal di F.L.