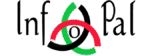Di Gabriele Repaci. Il Times of Israel, in un aggiornamento del 2 agosto 2025 a firma Emanuel Fabian, titola con soddisfazione: “IDF says Hamas’s Beit Hanoun battalion has been defeated; three operatives surrender to troops”.
L’esercito israeliano annuncia che il battaglione di Hamas attivo a Beit Hanoun, nel nord della Striscia, è stato neutralizzato. Tre miliziani si sarebbero arresi uscendo da un tunnel, portando i soldati a un deposito di armi. L’ennesima “vittoria tattica” israeliana viene raccontata al pubblico come una prova di progresso, di ordine ristabilito.
Ma basta scorrere poche righe dell’articolo per cogliere una crepa nella narrazione:
“L’IDF ha operato a Beit Hanoun cinque volte dall’inizio della guerra, degradando gradualmente il battaglione di Hamas nella zona.”
Cinque volte.
Cinque dichiarazioni di bonifica.
Cinque ritorni.
Beit Hanoun, simbolo di questa guerra, non è mai davvero “liberata”. Ogni incursione genera un vuoto momentaneo, che viene poi riempito di nuovo da ombre che riemergono dalla rete infinita dei tunnel. È l’immagine perfetta di un conflitto che non avanza, non conclude, ma gira su sé stesso, come un ouroboros, il serpente mitologico che si morde la coda.
Il ventre vivo della terra.
La vera chiave di lettura non è la superficie — le rovine, i veicoli blindati, i proclami militari.
Il cuore della resistenza è sotterraneo, oscuro, tenace.
Hamas non si batte per tenere il terreno: si batte per non scomparire, per colpire quando meno te lo aspetti.
Ogni volta che l’IDF dichiara un’area “sicura”, crea le condizioni ideali per essere colpita. I soldati abbassano la guardia, si rilassano, pensano che la fase peggiore sia alle spalle. È lì che il nemico ritorna — non per riprendersi la città, ma per distruggere la certezza di aver vinto.
Una guerra pensata per non finire.
La guerra asimmetrica non si vince con bandiere issate o quartieri occupati.
Si vince — o si perde — nella mente di chi combatte e di chi osserva.
E in questo senso, l’IDF è costretta a giocare una partita logorante:
Se mantiene l’allerta costante, i soldati crollano.
Se concede tregue operative, diventano bersagli.
Se dichiara vittorie premature, perde credibilità.
Se tace, viene accusata di fallimento.
Hamas, dal canto suo, non ha bisogno di vincere. Le basta resistere, riemergere, smentire la narrativa israeliana con un singolo attacco ben piazzato. L’illusione della vittoria israeliana è la condizione ideale per la sua rovina simbolica.
Il dilemma senza uscita.
Non si può vincere davvero, ma non si può nemmeno ritirarsi.
Per Israele, lasciare Gaza significherebbe ammettere che dopo mesi di carneficina e devastazione urbana, il nemico è ancora lì — vivo, armato, invisibile.
Per Hamas, ogni attacco — anche suicida — è un atto di sopravvivenza narrativa.
Siamo dentro un ciclo autoreplicante, in cui ogni azione genera la propria reazione, ogni battaglia prepara la prossima, e ogni annuncio di vittoria è un’esca per l’umiliazione successiva.
Beit Hanoun non è un luogo. È un simbolo.
È il simbolo di una guerra che non può finire, perché non è stata progettata per concludersi, ma per ripetersi.
Come l’uroboro, Gaza si morde la coda.
E nel frattempo, sotto i nostri occhi e sopra le macerie,
una generazione intera viene consumata nel fuoco ciclico della guerra eterna.